Babushka
Sotto casa mia – una palazzina grigia di quattro piani sulla strada principale del centro, con ingresso rialzato sul retro del palazzo, di fronte a uno sgarruppato cortile e parcheggio male organizzato – stazionano stabilmente, dalle sei alle otto di sera, tre babushka, tre nonnine. Che poi non penso siano poi così anziane, forse hanno da poco superato i settant’anni, forse sono alla soglia dei settant’anni. Si autodefiniscono nonnine (è una delle poche cose che capisco quando le incontro sulle scale e mi lasciano il passo, “пожалуйста, я бабушка” mi dicono, “passa prego, io sono una nonnina”) e aderiscono perfettamente all’ideale della nonnina di città. Ogni volta che torno a casa con qualcuno mi sento i loro occhi addosso, un po’ protettivi un po’ giudicanti: io le saluto, loro ricambiano all’unisono; ogni volta che chiudo il portone di ingresso con un poca attenzione, e questo sbatte pesante nel suo metallo militare grigio, sento il loro sguardo di disapprovazione sulla schiena, e sguscio dentro il palazzo senza voltarmi. L’altro giorno tornavo da una corsa, sudatissimo (l’estate qui è torrida): una di loro, la mia vicina di casa, si alza dalla panchina vedendomi arrivare, e mi fa cenno con la mano di avvicinarmi. Così faccio, e inizia una simpatica conversazione nella quale, in qualche modo, ci capiamo (la farò breve: ogni mese la babushka raccoglie 25 grivna da ogni appartamento della scala per pulire le scale – io non avevo ancora pagato il mese). Salgo a casa, mi faccio una doccia e scendo con le 25 grivna (ma ho solo un pezzo da 50, quindi pago per due mesi), e a quel punto colgo l’occasione per chiedere come si chiamino, le mie babushka: avrei fatto fatica a ricordarmene tre, di nomi, così concentrato com’ero nel non sbagliare di troppo le mie poche frasi in russo per bofonchiare un “меня завут даниеле”. Di nomi però me ne arrivano sei. Ovviamente, non ne ricordo mezzo.
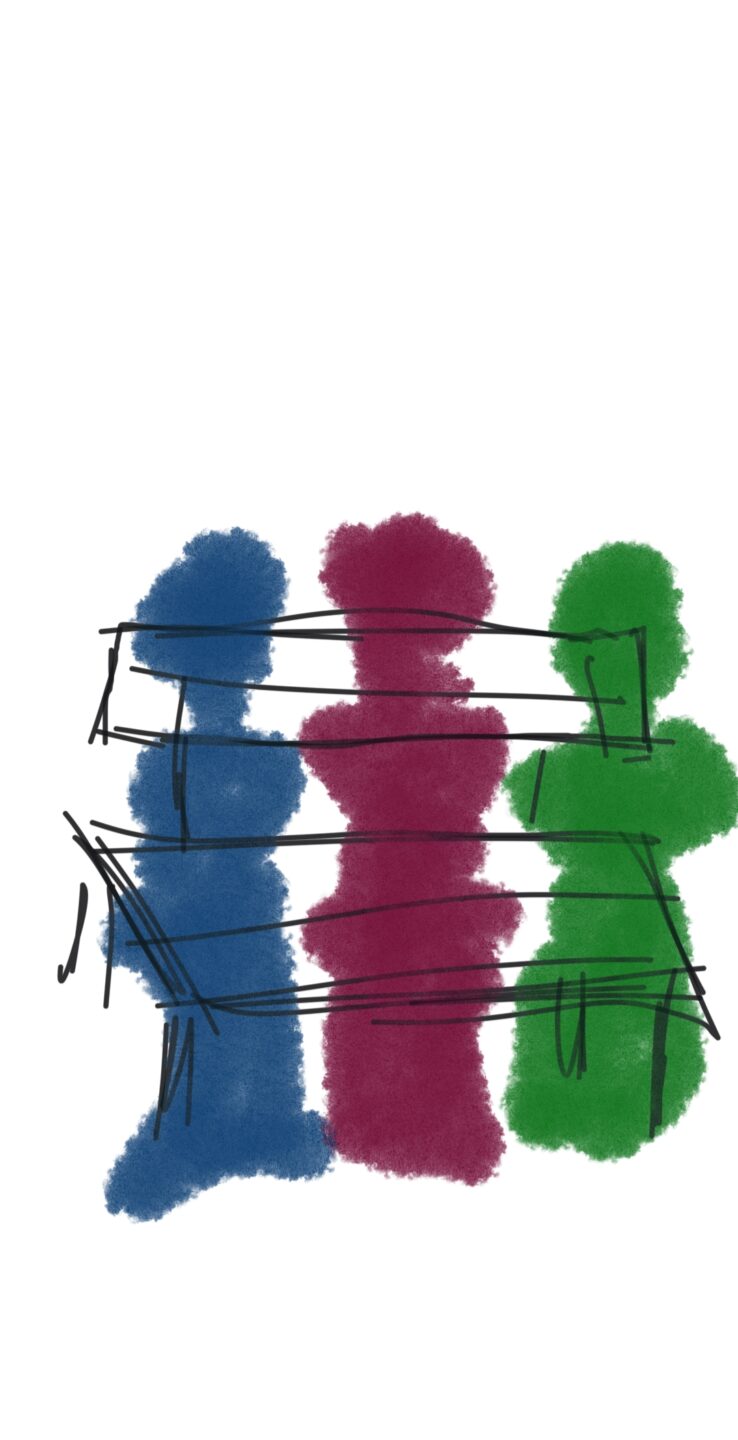
Patronimici
Eppure lo avrei dovuto sapere, che di nomi me ne sarebbero arrivati sei, e non tre. Anzi: da qualche mese speravo di avere la possibilità di presentarmi a una signora che, nel dirmi il suo nome, avesse aggiunto il patronimico. Irina Ivanov’na. Tatiana Antonov’na. Evgeniia Alexandrov’na. Io di letteratura russa sono assolutamente digiuno, però associo il patronimico a ambientazioni letterarie, a mondi ottocenteschi o del primo novecento (prima della Rivoluzione d’Ottobre, anche se pure Lenin era Vladimir Ilyich). Quindi speravo, un giorno, di riuscire a rivolgermi, con tutto un rispetto pomposo un po’ macchietta, a una Anastasiia Petrov’na. O di imitare quella coppia di amici vicina al divorzio, che durante le discussioni un po’ più animate smettono di chiamarsi con il nome proprio e usano solo il patronimico, più per provocazione che per rispetto. E di nuovo mi trovo affascinato da come ci chiamiamo e facciamo chiamare: avevo appena lasciato l’Iraq, dove il rispetto porta a chiamare un padre e una madre con il nome del primogenito (Umm Muhamad, Abu Sharif), e ora in Ucraina mi trovo a dover conoscere il nome del padre, e non del figlio. Immagino voglia dire qualcosa, rispetto all’importanza del passato o del futuro, di ciò che è stato rispetto a ciò che verrà, di chi saremo rispetto a chi siamo stati.
Intermezzo, utile a capire quanto segue: nel ristorante da dove sto scrivendo, davanti al mio tavolo siedono tre donne molto belle, di diverse età – da quanto capisco e origlio, sono tutte e tre madri, e non me ne stupisco. Una di loro mi ha appena sorriso, dopo aver goffamente urtato il mio tavolo: si stanno concedendo qualche giro di cognac e cola. Tre tavoli più in là, due uomini della mia età stanno bevendo qualche birra di troppo, cercando di attirare le attenzioni della cameriera con grandi e simpatiche sbracciate (sempre meglio del девочка!, ragazza! con il quale qui si apostrofa la cameriera di turno). Mi sono fatto una risata alla loro coreografica ultima sbracciata, e ho alzato il bicchiere di birra per un brindisi a distanza. Ho smesso di ridere con loro, e di scambiare lo sguardo, quando ho visto che, nascondendosi poco e goffamente, stavano scattando fotografie delle tre donne di fronte al mio tavolo, guardandole con fare lascivo.
L’obbligo del padre
Per chi se lo fosse chiesto, il patronimico è un obbligo. Fa parte del nome ufficiale, ed è indicato nei documenti di identità. Per chi se lo fosse chiesto, il matronimico non esiste. Un giorno ho avuto il coraggio di chiedere a una collega: e chi nasce senza un padre? Temevo una pratica simile al nostro superato (ma non troppo) di NN, nomen nescio, con la quale si indicavano fino agli anni settanta i figli di padre sconosciuto. Qui la soluzione adottata è diversa: si indica il nome del padre della madre. Perché un padre è necessario, non se ne può fare a meno. Nessuna delle persone con cui ne ho parlato ci vede un grande problema – fa parte della tradizione, mi dicono. La lingua russa ha ancora enormi sessismi, che io vedo problematici e chi mi circonda meno: un uomo che si sposa “si prende moglie” (жениться, il verbo è riflessivo), una donna che si sposa “va dietro a un marito” (letteralmente, она вышла затуж). Questo penso significhi qualcosa, e quando provo a parlarne mi dicono che questa è una lingua antica, ma la realtà è diversa. L’altro giorno ho proposto a un amico di annunciare il suo matrimonio dicendo che starà “dietro a una moglie” – una soluzione più riparatrice che trasformatrice, lo so, e non so se la prenderà in considerazione.
Aggiornamento dal ristorante: il ragazzo sbracciante è venuto a chiedermi se stessi scrivendo un libro, visto che siedo così serio dietro il computer. Parlava un bell’inglese con un accento forzatamente americano, e ci siamo fatti due risate a caso mentre mi diceva le due parole di italiano che sa (cazzo di cane denota un minimo di fantasia in più rispetto al classico vaffanculo). Una delle donne nel tavolo davanti a me si è girata verso di me, a conversazione finita, e mi ha fatto un mezzo applauso. Al mio что? Cosa? mi ha detto, un po’ brilla, “you are a very beautiful boy”. Io ho sorriso un po’ imbarazzato, pensando all’uso del boy, ragazzo al posto del man, uomo, proprio ora che sto cercando di riconciliarmi con i miei trentadue anni e i primi, evidenti, capelli bianchi.
