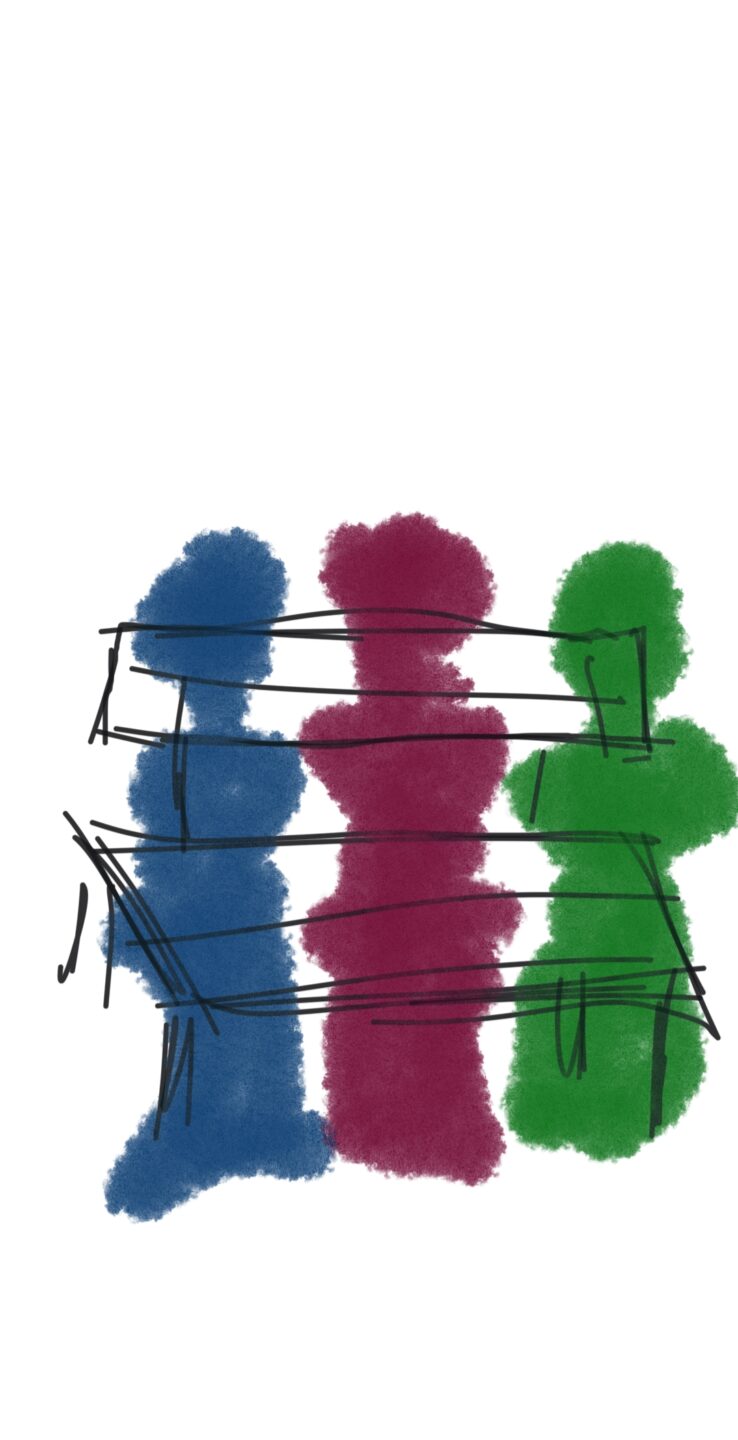Un ultimo sguardo, (*), all’arredamento…
Il monolocale nel quale ho vissuto in questi ultimi sei mesi era relativamente semplice: una cucina, una stanza principale, un piccolo bagno, ingresso e balcone. L’appartamento era stato recentemente ristrutturato, e penso di esserne stato il primo inquilino. C’è uno stile abbastanza diffuso in Ucraina, quantomeno qui nell’est, nel rinnovare gli appartamenti costruiti negli anni Settanta: il pavimento è in piastrelle lucide, 60×60, di finto granito; le pareti sono coperte di una carta parati ruvida e brilluccicante, di un bianco tendente al crema; il soffitto è tutto contro-soffittato, con un discutibile pannello traslucido e vagamente riflettente, dal quale spuntano troppi punti luce non necessari, e con l’inconveniente di non essere fisso, ma flessibile ai giri d’aria; il balcone è chiuso a mo’ di veranda, con una struttura di plastica e grandi finestre in vetro. Quasi tutti gli appartamenti rinnovati recentemente che ho visto hanno queste caratteristiche in comune. Il mio non era tra i migliori, che l’arredamento e la distribuzione degli spazi lasciavano un po’ a desiderare: il bagno, nel quale spiccava un box doccia semicircolare di vetro decorato con fantasie bianco e nero, era male organizzato, con un mobile di pseudo design moderno con un lavabo ovaloide quasi a ostruirne l’ingresso; la stanza principale era un rettangolo perfetto, vuoto, senza una minima separazione di zona giorno e notte (tanto che, dopo un mesetto, avevo deciso di spostare il grande armadio a specchio in mezzo alla stanza, per nascondere un poco il divano-letto verde oliva dai raggi del sole mattutini); la cucina era estremamente basilare, e non aveva un forno, ma aveva un tavolo sghimbescio dondolante a tre gambe. Quando visitai l’appartamento per la prima volta, la coppia che lo affittava (lei di Sloviansk, lui nato nel territorio dell’odierna Federazione Russa) insistette molto per farmi avere una televisione, noncurante delle mie opinioni a riguardo: per sei mesi una televisione enorme e un po’ vecchiotta è rimasta a impolverarsi, sempre spenta, sulla cassettiera in soggiorno.

*commosso
Ieri ho ripulito il monolocale, ho riempito le due valigie che mi sono portato dietro con tutto quello che contenevano quando sono arrivato, né più né meno. Nel chiudere la casa, ricontrollando ogni cassetto, ho provato un certo senso di dispiacere. Lasciare l’Iraq o il Sud Sudan è stato diverso: ero in una guesthouse, un posto comune a tanti altri, non mio soltanto. Non dovevo chiudermi la porta alle spalle e consegnare la chiave, che qualcuno l’avrebbe fatto per me. Se a Juba o a Erbil ho vissuto da expat, da lavoratore internazionale di un’organizzazione umanitaria, qui a Sloviansk ho avuto l’impressione di potere essere meno legato a quest’etichetta, più libero di vivere una vita normale. L’appartamento in cui ho vissuto ha fatto la sua parte, e per quanto lo abbia criticato, mi ha aiutato a sentirmi meno straniero: vivevo in un posto come tanti, in una città senza divisioni di posti, in mezzo a ricchezze e povertà non equamente divise, ma tutte reali. È una sensazione strana: ho lavorato in un contesto umanitario molto diffuso e in declino, dove ogni città (Sloviansk, Severodonetsk, Kramatorsk, Kostantinivka, Bakhmut) ha una sua piccola presenza di lavoratori internazionali, ben diluiti nella popolazione locale, tanto da essere quasi invisibili. Questo permette – se lo si vuole, e io ci ho provato – di sentirsi meno esclusi, meno privilegiati, più a contatto con il contesto. L’appartamento in Улица Университетскаиа 48, al primo piano, mi ha accolto immediatamente, al mio arrivo in marzo, e nel lasciarlo l’ho ringraziato, un po’ commosso.

… e chi si è visto si è visto
Avrei voluto passare almeno una giornata a Kyiv, prima di lasciare l’Ucraina. Ci ho passato invece poco meno di una notte, ma sono contento sia andata così. Avrei voluto prendere il treno notturno delle 23 da Sloviansk, il venerdì, ma non c’erano più posti: ho dovuto scegliere tra il treno pomeridiano di venerdì o quello di sabato. Ma venerdì l’organizzazione per la quale lavoro aveva organizzato un ritrovo informale di tutti i colleghi, sulla riva di uno dei tanti laghi della regione, e mi sarebbe dispiaciuto andarmene via a metà giornata per prendere un treno di corsa. Al ritrovo ho potuto parlare con colleghe e colleghi con cui avevo avuto poche occasioni di incontro, e ho potuto salutare, per quanto possibile individualmente, ogni persona con la quale ho lavorato in questi sei mesi. Di questo sono particolarmente contento: nonostante la difficile comunicazione a causa dei miei limitati progressi linguistici con chi parla solo russo e ucraino , ho sentito e provato un certo affetto a salutare molte delle colleghe e dei colleghi con cui ho passato questi ultimi sei mesi. Sloviansk è un altro puntino sulla cartina del mondo che difficilmente rivedrò, e fa sempre un po’ impressione distaccarsi da un presente molto vivo e immaginarlo già passato.