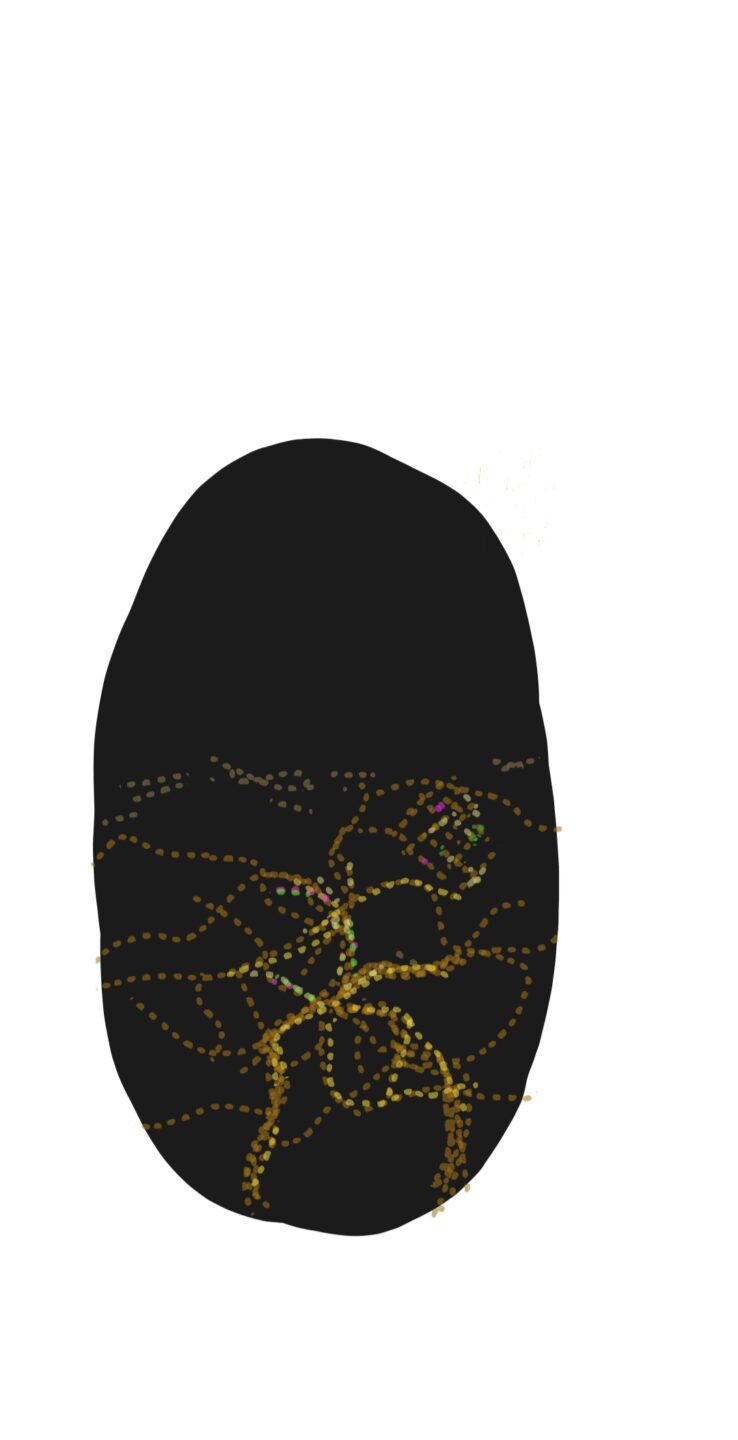La campagna mi era familiare, eppure non ero mai stato lì. Itzehoe, Meldorf, Krumstedt. Paese, Carità, Villorba. Si sentiva solo, un po’ più pronunciato, l’odore del mare, ma la distanza era quasi la stessa. Itzehoe, Meldorf, Krumstedt. Paese, Carità, Villorba.
Romano Marchi detto Angelo, tra l’estate del 1943 e l’estate del 1944 passò dalla campagna di Paese, Carità, Villorba alla campagna di Itzehoe, Meldorf, Krumstedt. In mezzo, l’autunno del 1943 in Albania, l’inverno del 1944 in treno e la primavera dello stesso anno, tra Brema e Amburgo.
Romano Marchi detto Angelo è mio nonno, e mi chiedo se anche a lui, al primo arrivo, quella campagna dovesse sembrargli familiare. Ne dubito.
I documenti ufficiali del Regio Esercito Italiano mi dicono che il 10 giugno del 1943 Romano Marchi è rientrato nella 605esima compagnia mitraglieri in Albania, il 17 settembre del 1943 è catturato dalle forze armate tedesche e internato in Germania, l’8 maggio 1945 è liberato dalle truppe inglesi, il 22 agosto 1945 rimpatriato dalla prigionia. I documenti ufficiali del Terzo Reich mi dicono che dal 20 agosto 1944 al 17 maggio del 1945 è stato occupato come aiuto contadino, a Krumstedt (buffo come l’occupazione sia perdurata nove giorni oltre la liberazione). La memoria di mio nonno Angelo, ora, mi dice meno di queste scarne informazioni.
Nel marzo 2011, mentre studiavo a Berlino, mi ritrovai un po’ per caso ad Amburgo. L’anno prima, Romano Marchi detto Angelo aveva ricevuto la Medaglia d’Onore come cittadino italiano deportato e internato nei lager nazisti. La richiesta di concessione della Medaglia d’Onore fece riemergere, in famiglia, vari documenti storici di quegli anni e io, bilingue tedesco per fortuna e coincidenza, li lessi come un grande regalo. Sentivo anche di dover saldare un debito per un altro regalo, quello perso: parecchi anni prima, quando ancora la memoria non vacillava, Romano Marchi detto Angelo, mio nonno, si era lasciato intervistare, davanti a un registratore, nella cucina della vecchia casa contadina di Villorba, riguardo alla sua esperienza nella Seconda Guerra Mondiale. Quella cassetta non riuscì più a trovarla, e tutt’ora mi sembra la più grossa perdita materiale della mia vita. Ero ad Amburgo, e Itzehoe, Meldorf, Krumstedt distavano solo poche decine di chilometri. Sentivo il dovere morale, oltre alla curiosità, di andarci.
Mio nonno non ha mai parlato molto della Seconda Guerra Mondiale, anche se sarebbe più corretto dire che mio nonno non ha mai parlato molto e basta. Tornato in Italia sposò Filomena Pizzolato, che in quegli anni l’aveva aspettato; tra il 1948 e il 1966 ebbero quattro figli e quattro figlie; fino a qualche anno fa ha continuato a lavorare, instancabilmente ma sempre più stanco, una campagna di pura sussistenza: c’era poco tempo per le parole. Con le figlie e i figli solo accennava, vagamente, a qualche ricordo della prigionia. Con la moglie, non lo so dire, ma non penso si dilungasse in confessioni. Con me bambino, quel giorno, seduti al tavolo in cucina in un pomeriggio di tarda primavera, mi aveva raccontato della cartolina, spiegato cosa fosse una piazza d’armi, dell’appendicite che quasi lo ammazzava, del ritorno in Albania e la consegna ai tedeschi, del viaggio in treno, verso la Germania, del tempo passato a Brema e a Amburgo a ripulire le strade dalle macerie, della malattia, della famiglia di contadini che l’aveva preso a lavorare, fino alla liberazione. Soprattutto il racconto di questa famiglia mi restò impresso: mio nonno ne parlava con riconoscenza, quasi con gratitudine, convinto che senza di loro non sarebbe mai tornato a casa. Ero ad Amburgo, ed ecco che i debiti diventavano due: la cassetta smarrita e un ringraziamento a chi, per eterogenesi dei fini, aveva permesso la sopravvivenza di mio nonno, la nascita di mio padre, la mia esistenza.
Krumstedt è un piccolo paesino di campagna, a qualche decina di chilometri dal confine con la Danimarca, nello stretto lembo di terra che dalla Germania continentale si spinge, senza un motivo apparente, verso nord. Per arrivarci, da Amburgo, si prende un treno fino a Itzehoe, poi un altro verso Meldorf, e poi da lì ci si arrangia per gli ultimi 10 chilometri. Seguivo la traccia di un documento: l’Arbeitsbuch für Ausländer del Reich tedesco – ancora oggi l’idea che nel 1944 la Germania nazista avesse chi si occupava di redigere un libretto di lavoro per stranieri a ogni prigioniero di guerra internato mi lascia incredulo. L’Arbeitsbuch sbagliava di un giorno la data di nascita di mio nonno (il 20 febbraio 1921 invece del 21), ma mi indicava il villaggio, Krumstedt, un nome, Heinrich Hennings, e una professione, Landes Betrieb, lavoro agricolo. Una veloce ricerca online mi diceva che a Krumstedt una famiglia di nome Hennings rimaneva. Valeva la pena tentare una visita.
Chi mi sarei trovato davanti? La Germania ufficialmente ha fatto i conti con il suo passato nazista, e nel 2011 i movimenti di estrema destra come Pegida e Alternative für Deutschland dovevano ancora mostrarsi. Però non tutti hanno voglia di rivangare il passato, e io non potevo sapere cosa ne fosse successo di Heinrich Hennings, ammesso che non fosse ancora vivo. Krumstedt è un paesino, ma ci sono ben un ristorante e un bar, che danno ristoro principalmente ai ciclisti che sfruttano le poco trafficate stradine di campagna. Era un sabato di inizio marzo, eppure non faceva freddo, e splendeva un bel sole che veniva voglia di camminare. Mi aggirai per il paese senza una meta, per capirne la fisionomia e fantasticare su quale casa fosse quella della famiglia Hennings. Krumstedt mi sembrava invecchiato abbastanza da non essere troppo diverso a quello di settant’anni prima: un piatto villaggio sonnolento con poco da offrire, oltre alla vasta campagna attorno. Case dai tetti spioventi, antichi e arrugginiti attrezzi agricoli nei cortili, un vecchio molino a vento a cui erano cadute le pale. Difficilmente le fattorie hanno insegne, e trovare quella della famiglia Hennings seguendo il fiuto sembrava complicato. Entrai nel ristorante, per bere qualcosa e chiedere informazioni. Era affollato di una famiglia in festa, forse per un compleanno, e non mi sembrava il luogo adatto per abbozzare una conversazione. Gironzolando trovai anche il bar, in una vecchia Dorfgemeinschaftshaus, una sorta di casa del popolo tedesca. Per mia fortuna era aperto, e una ragazza più o meno della mia età si mostrò stupita a vedere entrare una persona sconosciuta, dal vago accento straniero. Mi sedetti al bancone, ero l’unico cliente, e feci due chiacchiere con lei, che dopo una laurea a Amburgo aveva deciso di tornare al paese di origine, per gestire il piccolo bar. Costruita quella minima fiducia che permette di parlare di sé, le dissi della mia ricerca, e le chiesi se conoscesse la famiglia Hennings. La conosceva, e la fattoria non distava che qualche centinaia di metri; mi disse che erano persone tranquillissime, molto dedite al lavoro di campagna, e mi indicò la direzione. Rincuorato, uscì dal locale e mi avviai verso l’indirizzo. Ora veniva il difficile: come presentarsi, una volta suonato il campanello? Quali parole usare? Trovai la casa in fondo a una piccola stradina di campagna come molte: una casa di mattoni rossi a due piani, con il tetto spiovente massiccio e il granaio alle spalle. Il campanello diceva Familie Hennings: ero arrivato. Suonai quasi con pudore, mi rispose una voce di donna. Penso di averle detto: “Sono Daniele Marchi, uno studente italiano. Ho dei documenti che dimostrano che mio nonno ha lavorato qui, settant’anni fa”. Non ricordo esattamente cosa rispose lei, prima di aprire la porta; ricordo che a un certo punto la porta si aprì, e una signora dell’età di mia madre, alta con i capelli biondi corti e gli occhiali mi guardò stupita. Le mostrai le copie dei documenti che tenevo nello zaino, e lei riconobbe la firma del suocero, il signor Heinrich Hennings. Si mostrò incredula e incuriosita, e mi disse di entrare, che avrebbe chiamato il marito, che era ancora con le bestie nei campi. Mi accomodai in cucina: era una casa di campagna, una campagna un po’ più benestante di quella di mio nonno, con le stesse foto di famiglia alle pareti, i radiatori antichi e i mobili di legno. Nell’attesa, mi sentivo incredibilmente piccolo di fronte alla storia che stavo ripercorrendo.
La signora mi offrì un caffè, e mi disse che il marito sarebbe arrivato presto (ho dimenticato tutti i nomi di quella famiglia). Nel frattempo mi chiese di raccontare la storia di mio nonno, e io le dissi quello che sapevo, dicendole di come Romano Marchi detto Angelo fosse riconoscente a quella famiglia, che gli aveva salvato la vita. Mentre aspettavamo il marito, lei decise di fare alcune chiamate alle sorelle di lui che, più anziane, sicuramente dovevano ricordarsi qualcosa; lei invece era nata durante la guerra, e di quel periodo aveva solo informazioni di seconda mano. Parlò con sua nuora nel dialetto locale, che è un miscuglio difficilmente comprensibile di tedesco e danese, con qualche reminiscenza di inglese – e io non potevo non pensare al dialetto trevigiano, incomprensibile per chiunque non sia veneto. Mi passò la cornetta del telefono, e all’altro capo una voce di donna anziana mi raccontò che certo, si ricordava di un uomo italiano durante gli ultimi anni della guerra in cui lei era poco più che adolescente, e si ricordava di come questo le facesse il filo, promettendole di portarla con sé in Sicilia. Ovviamente, non parlava di mio nonno (che, oltre a non essere siciliano, faccio enorme fatica a immaginare guascone con le ragazze del luogo durante la prigionia), ma alcune storie sono troppo belle per essere smentite. Decisi di rispondere, semplicemente: “Das werde ich nicht meiner Grossmutter erzählen!” – questo no, non lo racconterò a mia nonna.
Altri documenti ufficiali mi dicono che a mio nonno fosse permesso, per esempio la domenica, muoversi liberamente nel villaggio, e che non fosse tenuto sotto custodia al di fuori delle ore lavorative. Come pensare a quelle domeniche di tempo di guerra in una remota campagna tedesca, con questi strani prigionieri di guerra quasi Gastarbeiter (i lavoratori stranieri, diventati poi centrali nella ricostruzione tedesca dopo la Seconda Guerra mondiale) che si muovono liberamente per il paese, e questo giovane siciliano che cerca di impressionare una ragazza tedesca parlandole di un futuro in Sicilia? Mi manca l’immaginazione per pensare a una situazione tale, perché della Seconda Guerra mondiale ho conosciuto attraverso scuola e libri soprattutto la ferocia, la brutalità e la determinazione dell’annientamento (e l’eroismo, il valore, e la lotta partigiana), e a volte mi dimentico che quella narrazione è necessariamente parziale, perché anche la guerra più annichilente è fatta di uomini e donne, spinti da desideri, da bisogni necessità e sogni, di uomini e donne. Perché anche la guerra più annichilente è una parte del vissuto, che può ingigantirsi ma non diventare il tutto: rimarrà sempre, per quanto nascosta, una speranza del poi.
Arrivò il marito, un uomo alto e allampanato sulla settantina, con gli occhiali e la tuta da lavoro, i capelli radi bianchi. Arrivarono anche i due figli, anche loro dai campi: uomini forti, robusti, dediti e gioviali. Furono sorpresi di sapere di me e della storia di mio nonno, eppure non ricordo quella sorpresa come qualcosa di troppo evidente o sbalorditivo. Era più uno strano diversivo a un sabato pomeriggio qualunque. Ripercorremmo, anche con le foto, la storia della famiglia Hennings, e mi fecero vedere alcune foto d’epoca, della famiglia riunita. Heinrich Hennings era anche lui sul fronte, durante la Seconda Guerra Mondiale, e per uno strano caso del destino combatté sulla Linea Gotica, sembra vicino a Rimini. Il padre, che all’epoca era poco più che un bambino, mi mostrò vecchi dipinti della casa, com’era un tempo, e qualche struttura – una scala, una porta – che esisteva anche all’epoca. Mi disse più volte che i lavoratori come mio nonno mangiavano su un tavolo a fianco alla cucina, e mangiavano lo stesso cibo che veniva preparato per tutti – non ce n’era tanto, che tutto era razionato. Patate, cavoli, altri tuberi. Mi disse che lui se li ricordava bene, e si ricordava che venivano trattati bene. Mi disse che, grazie al cielo, il nazismo aveva perso, che sennò chissà cosa sarebbe successo – e in queste parole non ci vedevo alcuna circostanza, ma una chiara e semplice presa di posizione.
Con una fetta di torta nel piatto e un caffè, parlammo di altro: della loro campagna, della mia famiglia e della loro, delle vacche, della vita a Krumstedt, dell’esperienza di uno dei figli, qualche anno prima, in una fattoria in Nuova Zelanda. Mi ritrovai a mio agio in quel mondo contadino che gira su sé stesso, con e come le stagioni e i cicli di vita di una vacca.
Itzehoe, Meldorf, Krumstedt. Paese, Carità, Villorba. La mia famiglia e la famiglia Hennings. Sovrapponevo, quel pomeriggio, due campagne e due storie che un vezzo della storia ha voluto fare incontrare. Nell’esperienza di Romano Marchi detto Angelo, nato a Villorba il 21 febbraio 1921, parte della 605esima compagnia mitraglieri, catturato dalle Forze Armate tedesche, internato in Germania e liberato dall’esercito inglese, non posso dimenticarmi che il protagonista è un contadino, non un soldato né un prigioniero di guerra. Solo un errore della storia, un virus guerrafondaio, l’hanno costretto a vestire i panni del soldato e del prigioniero di guerra, ma lui non è mai entrato nella parte. Un contadino che ha sempre sopravvissuto nella campagna.