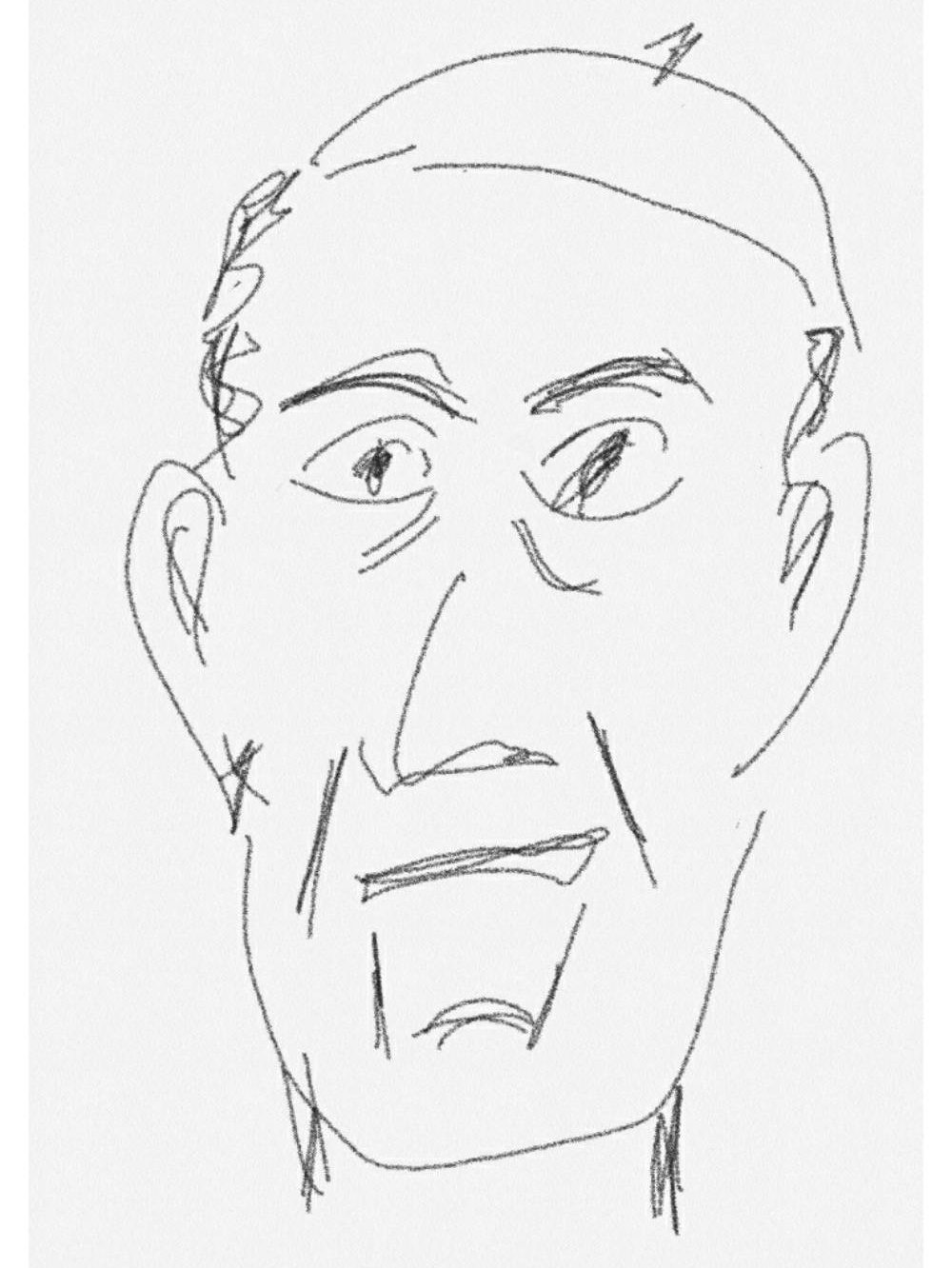Premessa
Il governo iracheno ha deciso di chiudere tutti i campi sfollati presenti sul suo territorio (precisazione necessaria, visto che i campi sfollati nel Kurdistan iracheno non verranno chiusi). La decisione non è una novità, ed è stata annunciata diverse volte negli ultimi anni. Diversamente dal solito, però, il governo iracheno ha anche deciso di mettere in pratica la decisione, chiudendo nel giro di qualche mese quasi tutti i campi sfollati – prima quelli attorno alla capitale Baghdad, poi quelli attorno a Kirkuk e altri vicino a Mosul. A ottobre circa 60 mila persone vivevano nei campi sfollati che sono stati progressivamente chiusi. Un numero relativamente basso rispetto alla situazione di un anno e mezzo fa, quando nel solo campo sfollati chiamato Airstrip, a sud di Mosul, vivevano circa trentamila persone. Ma un numero consistente, considerando che molte di queste persone non hanno un altro luogo dove andare (chi perché ha perso tutto, chi perché non verrebbe riaccettato nelle proprie comunità, chi perché ormai si era costruito una vita, nei campi). L’ultimo campo a essere stato chiuso, con un preavviso di 48 ore, è stato il campo di Salamiyah, vicino alla città di Hamdaniya/Qaraqosh/Bakhdida dove mi è capitato di lavorare. Alcune famiglie, quelle che hanno voluto o non potevano altrimenti, hanno accettato di essere trasferite nel campo di Jeddah 5, che si vocifera verrà chiuso a aprile ma per ora rimane uno dei pochi aperti. Per dare una mano al team che lavora a Jeddah 5, mi sono spostato per qualche giorno da Erbil; mi sembra una buona occasione per raccontare qualche storia.

Due uomini sudanesi
Un collega scrive sul gruppo Whatsapp: “Ci sono due sudanesi sul pullman in arrivo a Jeddah”. Chiedo e ricevo conferma, tra il sorpreso e l’insospettito. Ma è solo un altro segno dei miei preconcetti e della mia conoscenza approssimativa della storia di questo complicatissimo paese. Negli anni 80’ si contavano circa 350mila sudanesi in Iraq, arrivati in Iraq come forza lavoro – un accordo tra Saddam Hussein e Omar el-Bashir, allora presidenti autoritari di Iraq e Sudan, aveva facilitato le procedure di visto e arrivo. E i sudanesi in Iraq godevano di un’ottima reputazione, ed erano molto rispettati. Con la caduta di Saddam Hussein e la rovinosa situazione economica post 2003 le cose sono cambiate per tutti, e molti sudanesi residenti in Iraq (nel 2004 si parlava di qualche migliaio) si sono trovati bloccati nel limbo del migrante: rimanere, instabili, sperando che le cose tornino ad andare meglio, o tornare, magari a mani vuote, in un paese estremamente cambiato. I due uomini sudanesi che ho salutato oggi fanno parte della prima categoria.

Il professore
All’interno di un piccolo negozio – uno dei tanti che vendono un po’ di tutto, e che mostrano la grande capacità di adattamento delle persone – cerco di scambiare due parole con il proprietario. La conversazione è sostenuta quasi interamente dal mio collega, che il mio arabo ancora (quando mai) non mi permette di andare oltre i saluti di rito. Assieme al proprietario, intorno a un piccolo fornelletto a gas con la fiamma al minimo, è seduto un uomo, che mi guarda curioso. Scambio i miei salamalecchi anche con lui, che un po’ timidamente mi chiede, in inglese, da dove vengo. Parlottiamo un po’ aiutandoci con quel poco che abbiamo linguisticamente in comune, e mi dice che lui è, che lui era, un professore di chimica a Sinjar, prima di dover fuggire. Quel presente indicativo diventato velocemente imperfetto mi ha fatto pensare al film Il pianista, quando il protagonista, scoperto da un ufficiale tedesco in una casa intatta nella Varsavia distrutta, alla domanda “Wovon leben Sie?” (un che lavoro fa Lei? difficilmente traducibile) risponde “Ich bin.. ich war Pianist” (sono… ero un pianista). (per poi confermarlo suonando perfettamente la Ballata n.1 in Sol minore di Chopin, ma io non potevo certo chiedere una lezione in arabo sulla tavola periodica).

Una bella famiglia
Il settore O del campo sfollati di Jeddah 5 è completamente vuoto; da ottobre, più di mille famiglie hanno lasciato il campo, creando enormi aree desolate. Mi dispiace, che era un settore dove andavo sempre volentieri: ci viveva una bella famiglia che avevo seguito parecchio, assieme a un mio collega iracheno, che li seguiva da molto tempo più di me. Padre madre e vari figli e figlie – non ho mai capito quanti e quante, e chi fosse figlio e figlia di chi, che la madre era ancora incinta e la figlia maggiore aveva già partorito una o due volte. Non potevano tornare nella loro regione perché minacciati: da quanto ho capito, il figlio maggiore si era unito allo Stato Islamico, nonostante i tentativi del padre di fargli cambiare idea. Questo è sufficiente perché l’intera famiglia sia costretta a migrare di campo in campo, senza poter fare ritorno a casa per paura di ritorsioni. E, vedendo il settore O completamente vuoto, li immaginavo già altrove. Ma si erano solo spostati di settore: ho incontrato di nuovo la bella famiglia, Abu e Umm Amal (أمل, nome di fantasia e significato), e la piccola Maryia, che mi ha riconosciuto e non voleva che me ne andassi.